PERUGIA – La lingua italiana sempre più negletta, calpestata, oltraggiata. Non lo sapete? Numerosi candidati all’esame per l’accesso alla magistratura e all’avvocatura vengono bocciati per aver commesso madornali, imperdonabili errori di ortografia, di grammatica e di sintassi. E questi dovrebbero porsi come il fior fiore della classe dirigente dell’Italia… Che l’eloquio “del bel paese là dove ‘l sì suona” (citazione presa in prestito da Dante) sia sempre più misero e imbastardito lo conferma, ogni giorno, la televisione e lo attestano, ogni istante, i social sui quali molti frequentatori, anche di fama (ma de che?) si lasciano andare a strafalcioni che non i professori delle superiori, ma i maestri elementari di una volta avrebbero sottolineato con almeno tre freghi di matita blu, strappando nella foga, causata dal dispetto nel rilevare i macroscopici svarioni, persino il foglio del quaderno.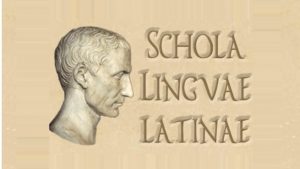
E allora pover’uomo, che fare? Nei giorni scorsi il ministro dell’istruzione, il professor Patrizio Bianchi si è lasciato sfuggire una sia pur tiepida idea di ri-apertura al latino nelle scuole. Perché il latino, oltre a far conoscere il passato e ad aprire la mente alla cultura classica (greca e romana), alla storia ed alla filosofia, alla giurisprudenza ed alla medicina, all’astronomia ed alle scienze naturali, può rivelarsi utile anche per una migliore costruzione delle frasi in italiano, a cominciare dal rispetto della “consecutio temporum”; può aiutare ad evitare di inciampare nelle impurità linguistiche; riesce a contribuire ad aumentare, negli studenti, la conoscenza ed il numero di vocaboli (le statistiche riferiscono che, in media, il cittadino italiano per esprimersi, nello scritto e nel parlato, pronuncia o ricorre a non più di 1200 parole: una miseria) A chi storce il naso all’ipotesi di re-introduzione nelle scuole dell’obbligo della lingua di Cesare e di Cicerone, di Virgilio e di Orazio, di Ovidio e di Catullo – idioma che, badate bene, fino al Settecento rappresentava la comunicazione principale ed universale in tutta Europa – varrà segnalare che la perfida Albione, sì, proprio l’Inghilterra, ha appena stanziato 40 milioni di sterline per lo studio del latino in quaranta scuole del Regno Unito.
 Gli inglesi, che hanno appreso i rudimenti della cultura dalle legioni romane stanziate nella loro terra, almeno fino all’altezza del “Vallum Adrianum”, hanno compreso l’importanza della lingua latina; noi, che calpestiamo la stessa terra di coloro che hanno contribuito a render diffusa la cultura in tutto il mondo, no: non arriviamo a renderci conto di questo semplice concetto. Intanto in Svezia una radio, con successo, trasmette in lingua latina; in Germania maneggiare gli scritti di Cicerone rimane abitudine inveterata delle élite culturali ed altrettanto succede in Francia ed in Spagna. Nelle nostre lande, invece, il latino è lasciato agli specialisti puri: insegnanti e docenti di lingue classiche. Che se la sbrighino da soli. E chi accenna una frase, un brocardo, un verso di una lirica in latino viene sbirciato con sospetto, tal’altra con irrisione. Eppure nessuno si rende conto (o ben pochi) dell’italiano deturpato e mutilato: dei tempi dei verbi non corretti e delle frasi sbrindellate che ne derivano; del cambio di soggetto nel corso di un discorso o di una argomentazione; di un’acca aggiunta dove non ci vuole o “sbadatamente” dimenticata (?) dove serve; degli accenti posti su “quì” e su “quà”, che partoriscono sgorbi da brividi; della pronuncia del tutto sballata, perché degli accenti si è perduto persino il ricordo, di un lemma; di parole in libertà spacciate per poesia, perché la rima è (apparentemente) rispettata, ma in dispregio della metrica, del ritmo, del numero delle sillabe. E mi fermo qui.
Gli inglesi, che hanno appreso i rudimenti della cultura dalle legioni romane stanziate nella loro terra, almeno fino all’altezza del “Vallum Adrianum”, hanno compreso l’importanza della lingua latina; noi, che calpestiamo la stessa terra di coloro che hanno contribuito a render diffusa la cultura in tutto il mondo, no: non arriviamo a renderci conto di questo semplice concetto. Intanto in Svezia una radio, con successo, trasmette in lingua latina; in Germania maneggiare gli scritti di Cicerone rimane abitudine inveterata delle élite culturali ed altrettanto succede in Francia ed in Spagna. Nelle nostre lande, invece, il latino è lasciato agli specialisti puri: insegnanti e docenti di lingue classiche. Che se la sbrighino da soli. E chi accenna una frase, un brocardo, un verso di una lirica in latino viene sbirciato con sospetto, tal’altra con irrisione. Eppure nessuno si rende conto (o ben pochi) dell’italiano deturpato e mutilato: dei tempi dei verbi non corretti e delle frasi sbrindellate che ne derivano; del cambio di soggetto nel corso di un discorso o di una argomentazione; di un’acca aggiunta dove non ci vuole o “sbadatamente” dimenticata (?) dove serve; degli accenti posti su “quì” e su “quà”, che partoriscono sgorbi da brividi; della pronuncia del tutto sballata, perché degli accenti si è perduto persino il ricordo, di un lemma; di parole in libertà spacciate per poesia, perché la rima è (apparentemente) rispettata, ma in dispregio della metrica, del ritmo, del numero delle sillabe. E mi fermo qui. 
In casa nostra, il latino venne “cacciato” dalle medie, come Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, a partire dal 1977-78. Mancò – da parte di tutti, sia chiaro – una difesa strenua: la battaglia appariva persa già dall’avvio. E così non si trovò alcuno che, nelle sedi opportune, si appellasse ai richiami, pure espressi da diversi intellettuali e pensatori, secondo i quali l’estromissione del latino dalle aule avrebbe causato un impoverimento culturale profondo e generalizzato. Alcuni assumevano posizioni snobistiche (“É la lingua dei signori”, sebbene, in realtà, la studiassero tutti nella scuola dell’obbligo); altri si appigliavano a considerazioni semplicistiche (“É una lingua morta, non serve a nulla”); taluni si aggrappavano a discorsi unti e consunti (“Meglio un lingua moderna, come l’inglese”. Ma l’una e l’altra, no?). Eppure già don Milani aveva insegnato ai ragazzini del Mugello, figli di contadini, di operai, di piccoli artigiani, che studiare era un modo, il migliore, per uscire dall’emarginazione sociale. I “nemici”, ciechi e sordi, del latino – appollaiati a destra, a sinistra, al centro – sbandieravano ai quattro venti motivazioni politiche (“Il regime fascista ha sguazzato, nel richiamo all’impero, in lungo e in largo, meglio tenersene alla larga”); ideologiche (“A cosa può servire alle classi più disagiate una lingua “morta?”); o di mera utilità immediata (“Meglio materie professionali in grado di avviare al lavoro”; così da perpetuare la mancanza di una scala sociale o da rendere più difficile la progressione verso l’alto).
Ora, trascorsi sette lustri, arriva un ripensamento: ci si accorge che, forse, il latino avrebbe potuto rivestire una sua preziosa funzionalità all’interno di una società più consapevole. Di per se stesso e, di riflesso: per impedire o per lo meno contenere, lo sfascio continuo e irrefrenabile, nel quale si è impantanata la lingua italiana. Nessuno si illuda: non se ne farà nulla. Il latino sopravviverà solo e negletto nei licei e nelle facoltà umanistiche. Se va bene. E gli italiani continueranno, senza vergogna alcuna, senza rossori alle gote – anche perché ad accorgersene ci saranno sempre meno orecchie attente e sensibili – a sfoderare in parlamento, nelle aule dei tribunali, nelle corsie degli ospedali, ahimè, sui giornali, alla radio, alla televisione frasi zoppicanti, anacoluti ricorrenti, tempi verbali stridenti come un gesso strisciato sulla lavagna. Il tutto in un carosello di pressappochismo, faciloneria, trascuratezza e, via, diciamolo, di ignoranza crassa. A coloro che sostengono che non è di alcuna praticità ed efficacia per i ceti più disagiati conoscere il latino basterà replicare di guardarsi intorno.
 Lì, si staglia la figura prestigiosa del figlio orfano di un falegname diventato un accademico di primo livello; di là, si intravede la figura luminosa di un medico di alta specializzazione uscito dalla casa di un modesto sarto; laggiù, avanza, con passo sicuro, la prima di una famiglia di contadini a porsi il lauro dottorale sulla fronte, orgogliosa di aver mietuto successi rilevanti nel mondo delle professioni; qui, al vostro fianco, potrebbe capitarvi di trovarvi seduti accanto ad un silenzioso poeta, di quelli che applicano davvero la stilistica e la metrica, il cui padre svolgeva le mansioni di muratore. Domani, tutto questo, diverrà sempre più difficile. Questo fenomeno di crescita sociale risulterà sempre più raro. Tecnici di vaglia, parleranno come carrettieri; luminari di chirurgia faticheranno a comporre frasi corrette per i loro articoli sulle ricerche e sulle scoperte effettuate; tra i rappresentanti del popolo in parlamento sempre meno saranno coloro in grado di pronunciare un discorso degno di tale definizione o redigere il testo di una legge senza “orrori” grammaticali e sintattici. E la lingua italiana sempre più immiserita, nella forma e nella sostanza, finirà per sparire surclassata da altri idiomi. Contenti voi…
Lì, si staglia la figura prestigiosa del figlio orfano di un falegname diventato un accademico di primo livello; di là, si intravede la figura luminosa di un medico di alta specializzazione uscito dalla casa di un modesto sarto; laggiù, avanza, con passo sicuro, la prima di una famiglia di contadini a porsi il lauro dottorale sulla fronte, orgogliosa di aver mietuto successi rilevanti nel mondo delle professioni; qui, al vostro fianco, potrebbe capitarvi di trovarvi seduti accanto ad un silenzioso poeta, di quelli che applicano davvero la stilistica e la metrica, il cui padre svolgeva le mansioni di muratore. Domani, tutto questo, diverrà sempre più difficile. Questo fenomeno di crescita sociale risulterà sempre più raro. Tecnici di vaglia, parleranno come carrettieri; luminari di chirurgia faticheranno a comporre frasi corrette per i loro articoli sulle ricerche e sulle scoperte effettuate; tra i rappresentanti del popolo in parlamento sempre meno saranno coloro in grado di pronunciare un discorso degno di tale definizione o redigere il testo di una legge senza “orrori” grammaticali e sintattici. E la lingua italiana sempre più immiserita, nella forma e nella sostanza, finirà per sparire surclassata da altri idiomi. Contenti voi…
Elio Clero Bertoldi









Lascia un commento