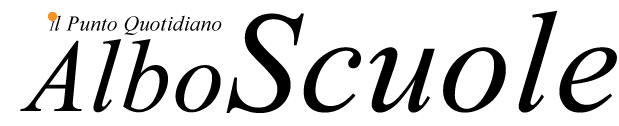di Patrizia Sereno – Hanno capito i ragazzi della Prima E. Hanno capito e si sono emozionati. Hanno capito, si sono emozionati e si sono commossi. Il legame tra me e loro è diventato più empatico da quella lezione in poi.
Riflettevano da tempo sui diritti dell’infanzia, lungo un percorso legato al 20 novembre. Avevano trattato il tema dei diritti dei più piccoli grazie anche ad una serie di letture proposte da loro testo di antologia. Avevano realizzato un cartellone (quello della foto) e si erano lasciati coinvolgere emotivamente dalla storia di Iqbal. Avevano anche svolto delle ricerche. Ed è a quel punto che è accaduto!
Leggevano sui loro quaderni i miei ragazzi di Prima E: diritto allo studio, diritto al gioco, diritto a non essere minacciati dalle brutture della guerra, diritto al nome… Ed io cercavo di declinare il più possibile i vari diritti, con esempi concreti, con il richiamo anche a pagine buie della nostra storia (il destino dei bambini ebrei resta sempre impresso nel cuore di tutti). Una pausa e poi, all’improvviso, il racconto…il mio vissuto si è fatto strada in maniera quasi autonoma.
Sapete, ragazzi, oggi diamo tutto per scontato, ma c’è stato un tempo, un tempo in cui non era esattamente così. Non era così neanche per il diritto ad un nome… Mio nonno paterno si chiamava Matteo Sereno. Era figlio di un nobile di un piccolo centro del Cilento. Di quel nobile e della cameriera. Un figlio illegittimo che, appena nato, era stato lasciato in un brefotrofio di Salerno (poi andato distrutto da un incendio, almeno così mi racconta il mio papà). Lì gli avevano dato nome e cognome: Matteo, come il Santo patrono della città; Sereno perché pare fosse un bambino tanto tanto buono e tranquillo. A proposito di diritto al nome!!! Crescendo, era stato affidato ad una famiglia di Nocera Inferiore. Una famiglia che lo aveva amato e che lui aveva amato. Tanto che, anni dopo, grandicello, aveva detto di no al suo vero papà giunto a Nocera per riprenderselo, dopo che – morta la moglie – aveva sposato la cameriera, la mamma di mio nonno. Un titolo nobiliare, un patrimonio, il blasone. Nonno Matteo aveva rifiutato. La sua vita era a Nocera. I suoi affetti erano a Nocera. Nonostante la sua vita non fosse certo priva di sacrifici. Sapeva fare ogni tipo di lavoro, nonno Matteo. Ma era soprattutto un taglialegna. Un giorno aveva sposato una ragazza bellissima, Filomena, e da lei aveva avuto quattro figli, tra cui il mio papà, Vincenzo. Un bagno refrigerante nell’allora limpida e cristallina Cavaiola, di rientro a casa, aveva condannato a morte la bellissima nonna Filomena che a soli 29 anni era morta di broncopolmonite… Ah, la penicillina…quella sconosciuta…
Nonno Matteo aveva sofferto, ma aveva pensato bene di risposarsi, per dare una mamma ai suoi figli. Vincenzo aveva poco meno di cinque anni e Mario, l’ultimo, 18 mesi. Dalle nuove nozze erano nate tre figlie, ma la nuova moglie di nonno Matteo non era riuscita ad amare i figli nati dal precedente matrimonio. O, almeno, non era riuscita ad amarli come fossero suoi. Il mio papà e sua sorella maggiore erano cresciuti sulle montagne del Cilento, al seguito del loro papà, lavorando duro e combattendo la fame. Diritto al gioco? Eh. Qualche calcio tirato ad una pietra o a al riccio di una castagna. Qualche sasso lanciato al rimbalzo sull’acqua. Artigianali giochi di abilità con dei rametti… A volte capitava che rubassero finanche le carrube ai cavalli, quando le solite patate lesse non si profilassero come il miglior cibo del mondo o quando non fosse festa grande per la zuppa donata dalla moglie di buon cuore di un massaro per cui papà e sua sorella avevano fatto qualche lavoretto. Papà racconta delle sue scarpe – un solo paio – senza quasi suole e del povero cappotto, risvoltato più e più volte perché assolvesse al suo compito di fare un po’ di calore, lassù in montagna, nonostante fosse liso e consunto…Sapete, quando il mio papà parla, quando racconta …è la storia che parla. Me ne sono resa conto anni addietro, leggendo Pane Nero di Miriam Mafai. Man mano che leggevo, mi rendevo conto che quella storia, quelle storie, io le conoscevo già. Le gallette dolci portate dagli alleati e distribuite ai bambini affamati, il ddt spruzzato con le pompe a spalla usate per il verderame in campagna, tanti erano i pidocchi con cui, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, qui dalle nostre parti erano abituati ad avere a che fare grandi e piccini. Insieme alla fame e alla povertà…Ops, scusate…vi ho annoiato?
Non ottengo risposta. Ma mi accorgo di diversi occhi lucidi qua e là. Hanno capito i ragazzi della Prima E. Hanno capito e si sono emozionati. Hanno capito, si sono emozionati e si sono commossi. Il legame tra me e loro è diventato più empatico da quella lezione in poi.