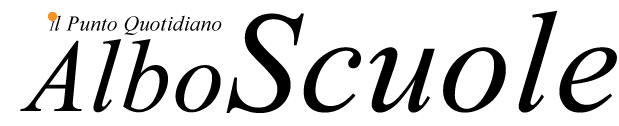di M. Calenzo –
Per comprendere quale ruolo ha oggi il mito, forse è opportuno interrogarsi innanzitutto sul processo di poiesi mitologica: l’investimento di significati simbolici su un significante oggetto, il cui concetto subisce un’espansione e un sovraccarico tali da farne un idolo o un feticcio. Mito non è soltanto un racconto o una narrazione. Il mito è un prodotto dalla forte potenza immaginifica che nasce da un processo di proiezione valoriale, un’operazione ideologica. Si assume una cosa come se essa significasse altro da quella che è. Si prende un oggetto e lo si deforma, ingrandendolo e gonfiandolo, per trasformarlo nel simbolo di qualcos’altro. Nel processo di superfetazione simbolica si espande la capacità dell’oggetto di comunicare idee e valori in modo immediato, suscitando emozioni e agendo da catalizzatore pulsionale. La società di massa ha continuamente bisogno di produrre miti siffatti per soddisfare un’esigenza collettiva di consumo. Il mito è un oggetto consumistico, che una volta prodotto si impone alle coscienze e ne dirige l’attenzione. Nella sua tendenza vettoriale, il mito tende a proiettare lo spirito collettivo in alto, tradendolo e distraendolo in basso. Esso è cioè il risultato di un’estraneazione della coscienza, che cerca fuori di sé ciò che essa non ha in sé, ma che proprio essa stessa produce entro sé. Alienazione simile a quella religiosa di cui parlava Feuerbach, e che nasce però secondo l’indicazione di Marx dal desiderio materiale insoddisfatto. L’idolo distrae l’attenzione e, agendo da narcotico per le masse, si sostituisce all’appagamento di bisogni reali e serve da giustificazione ideologica del sistema, favorendone l’accettazione anche da parte di chi ne risulta escluso o danneggiato. Il desiderio materiale si converte in desiderio ideale, il cui soddisfacimento sta tutto lì, pronto per essere consumato senza alcuno sforzo. Perché l’oggetto simbolico acquisti la sua forza, è necessaria la sospensione dell’incredulità, è necessario che l’occhio sociale si offuschi e rinunci all’esigenza di controllo razionale del dato. Tutto deve essere immediato, perché l’assenza di mediazione concettuale è il canale per la rapida accettazione. Non si ragiona sul simbolo, ma lo si vede già esteriorizzato e lo si vive reinteriorizzandolo. L’unica richiesta è che esso sia visibile, che si mostri offrendosi alla chenosi dell’incarnazione. L’oggetto deve essere tangibile e tuttavia lontano. Deve ispirare nella sua lontananza una ideale vicinanza al soggetto che lo venera. L’idolatrato e l’idolatrante devono perciò somigliarsi. Ecco che allora il mito, quando si incarna in un personaggio, deve assumere un doppio volto, uno chiaro e luminoso, espressione delle nostre aspirazioni ideali, un altro oscuro e tenebroso, che ci ricorda la nostra origine. Nel mito deve brillare l’idealità mescolata con la trivialità, affinché l’uomo comune resti confermato e rassicurato nella sua mediocrità. Questa rassicurazione è funzionale all’ordine sociale, che in tal modo risulta inalterato e rafforzato. Anche quando la simbologia mitica ostenta con veemenza la forza risolutiva per un presunto attacco al sistema, essa non lo intacca minimamente e non riscatta proprio nulla. Anzi, la credulità nel riscatto è parte integrante dell’ordine, che deve sempre in qualche modo alimentare anche la tentazione di fuga dell’uomo; tentazione che però resta solo ideale in quanto poi non si va da nessuna parte: è nell’ordine che si dà l’unico spazio di consumo e di esistenza possibile. Quella fuga ideale deve mostrare qui e ora possibilità inesplorate di un impossibile altrove, che proprio perché impossibile rinvia costantemente all’accettazione del quotidiano. In quelle possibilità vive l’elemento perennemente giovane del mito. Il mito non invecchia. Perché conservi inalterata la sua forza simbolica e persuasiva, deve mostrarsi con i contorni di una eterna giovinezza. E allora esso assume la forma di una vita cristallizzata negli anni furiosi dell’adolescenza. I personaggi che il sistema offre in pasto alle masse appaiono congelati in un infinito istante della loro giovinezza. Spesso nemmeno loro hanno conosciuto un seguito, essendo andati incontro a morte prematura. Quell’istante congelato si offre ad una visione ripetuta, ad un consumo compulsivo e maniacale che sempre si rinnova nei soggetti passivi del marketing tribale. Questa passività a cui ci inchioda è la vera forza del mito. Il soggetto libero, per esser tale, avrebbe bisogno di agire, ma l’azione è difficile e impegna la responsabilità. La via della prassi trasformatrice è irta di pericoli. La libertà spaventa perché comporta dei rischi. Allora si preferisce restare fermi, bloccati dalle catene invisibili dell’idolatria che ci tiene beatamente addormentati col suo oppiaceo. Perché uno dovrebbe tentare di vivere, quando può starsene comodamente in poltrona a consumare miti? Il prigioniero disabituato alla libertà ha sempre amato le mura del suo carcere.