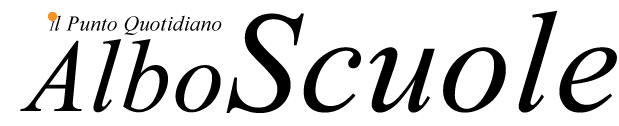di Camilla Rebonato e col contributo di Lorenzo Ruffin – Con il testo “La grande migrazione” (Einaudi 1993), Hans Magnus Enzensberger vuole spiegare la sua idea di nazione. Partendo dalle origini racconta che tutta la specie umana proviene da uno stesso continente, l’Africa. Sarà poi la migrazione a diffondere l’Homo sapiens in tutti gli altri territori. Già con questa premessa gli riesce quindi impossibile sostenere la tesi di una nazione formata da persone della stessa etnia eliminando quindi anche il concetto di razza. Procedendo con la sua argomentazione ripropone il discorso ‘migrazione e nomadismo avvalendosi di due esempi: il primo è culturale, il mito di Abele e Caino, in cui vediamo un nomade e un sedentario sfidarsi. Sarà il secondo a vincere, ma ciò non gli garantirà la terra, anzi, verrà cacciato per punizione da Dio.
Il secondo esempio è più realistico e facilmente riconducibile all’ esperienza personale di ciascuno. Ci mostra un viaggio in treno, dove due passeggeri, che chiameremo ‘originari’, dovranno far posto ad altri due saliti nel frattempo. Anche se il concetto di ‘passeggero’ è in sé riconducibile al nomadismo, possiamo avvertire un senso di fastidio nascere negli ‘originari’, che si sentono padroni di quel territorio e si ‘coalizzano’ contro i nuovi venuti, gli ‘intrusi’. Se poi si ipotizza l’arrivo di altri due nuovi, vedremo che la solidarietà tra gli originari si rafforzerà e a questo sentimento di unione parteciperanno anche i due che prima ne erano esclusi: tutti e quattro insieme contro i ‘nuovi stranieri’, rappresentando così nel loro piccolo il concetto di ‘nazione’. Dunque per Ezensberger la nazione è un’idea astratta, che nasce da un evento o una sensazione passata che accomuna gli individui. Lo scrittore spiega poi come l’ospite, il nuovo venuto, lo straniero e l’immigrato siano sì tollerati, ma mai totalmente accettati. Questo, però, non ha una spiegazione razionale, è semplicemente una convinzione istintiva con cui ogni individuo deve convivere; saranno poi le leggi e le norme di comportamento, come l’educazione e la cortesia, a garantire tranquillità e ordine.
La metafora del treno, che Hans Magnus Enzensberger usa per spiegarci il trascorrere della vita, ha un finale dissonante o per citare l’autore “precario ed isterico” in quanto, se ad ogni venuto il numero di persone che prova lo stesso sentimento (di fastidio contro la novità) cresce, sì è vero che si avrà una nazione con molti individui, ma fondata su cosa? Sul fastidio?! Sulla prepotenza? E poi rimarranno sempre i nuovi: color da guardare in sordina, da incolpare, tollerati a fatica, senza un motivo valido per farlo.
Il passato che aveva accumunato le regioni italiane non era bastato al raggiungimento dell’unità: scontri, rivolte, battaglie, repressioni, morti hanno caratterizzato la nostra storia fino all’ indipendenza e unificazione. Come diceva Ernest Renan, l’Italia è la dimostrazione vivente che non è né l’etnia né la razza a fare la nazione; neanche quando, in gara con altre potenze, si sente improvvisamente compatta e solidale attraverso un sentimento nazionalista aggressivo ed egoista, che portò a un’impresa coloniale “violenta e isterica”, incapace di capire che le popolazioni indigene, tanto come quelle europee, avevano diritti, desideri, opinioni e sentimenti di appartenenza; e ciò fu causa di discriminazioni razziali, persecuzioni, genocidi, tutto velato dalla giustificazione ‘civilizzatrice’.
Oggi in Etiopia, territorio colonizzato dall’Italia sotto Mussolini, più precisamente a Macallè, laddove ancora Crispi, nel 1896, aveva portato a combattere il nostro esercito, Calzedonia ha aperto uno stabilimento e dato da lavorare a 110 persone in un territorio povero. Ciò fa piacere anche agli italiani che così un po’ si sentono sdebitati per la sottomissione coloniale cui hanno costretto quelle genti; ma mi sembra di poter dire che Enzensberger non ne sarebbe completamente compiaciuto: pagare stipendi di 50 euro al mese, come riferisce L’Arena, gli sembrerebbe soltanto un modo, da parte della proprietà, di sfruttare il minor costo del lavoro. Direbbe che queste non sono altro che misure adottate dal capitale che, quando deve guadagnare, abbatte ogni confine nazionale e muove flussi invisibili di denaro e, dietro a quelli, flussi ben più visibili di uomini.
L’intervista che Fabio Fazio ha fatto il 21/10/2018 a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è stata interessante e diversa: quante volte al giorno si sente dire che “ci sono troppi immigrati”, “perché ce li dobbiamo prendere tutti noi?”…Insomma, a meno che uno non sia sordo, alla fine un po’ di quel “nazionalismo aggressivo e isterico” di cui si parlava prima entra sicuramente in testa. Il vero impegno sta nel coraggio di rispondere a quei commenti: in fondo se noi fossimo nei panni di chi emigra non vorremmo essere accolti e aiutati?
Non siamo nessuno per criticare e men che meno per decidere chi far morire in guerra o sui barconi. Questo è ciò che Mimmo Lucano ha fatto: si è elevato dalla marmaglia e ha agito razionalmente e in modo egualitario, non semplicemente accogliendo i profughi per poi lasciarli in preda alle malelingue e al razzismo. Ha detto: davanti a una persona in difficoltà cosa si fa? La si aiuta. Ha dato nuova speranza a persone che non ne avevano più, ha creato negozi di artigianato, ha attivato servizi, come la scuola, che altrimenti il suo paese avrebbe perduto. Riace è diventato un paese multietnico, “pieno di colori, bellissimo” si emoziona il sindaco, durante l’intervista, “e se ci siamo riusciti noi, a Riace, uno dei posti più poveri d’Italia, si può fare ovunque!”.
Sempre grazie al sindaco Lucano ho capito quale sarebbe il mio ideale di cittadino: né l’etnia, né la razza, né le vecchie tradizioni, ma solo la voglia di contribuire al benessere degli altri.
Ogni umano ha il diritto di vivere dove vuole, la terra è di tutti, tutti siamo nomadi.
E’ nella nostra natura spostarci, insediarci in posti nuovi: perché limitarci, imponendo confini territoriali e barriere mentali? Dobbiamo imparare il rispetto, favorire l’integrazione, quella vera, e per farlo dobbiamo scendere da quel piedistallo immaginario da cui ci ostiniamo a guardare gli altri.