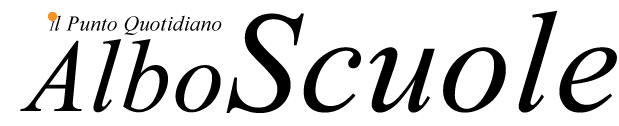L’Undici Gennaio 2020, con i nostri genitori, siamo partiti verso la Polonia,
destinazione Cracovia.
Non è il primo viaggio che abbiamo affrontato insieme ma è stato decisamente quello
più profondo, più emozionante, perché ci ha portato in uno dei posti simbolo dello
sterminio di milioni di persone, ebrei e non. Non avevamo ben chiaro cosa ci
attendesse ma sapevamo di certo che sarebbe stato un viaggio che ci avrebbe segnato
nell’animo.
Cracovia in quei giorni era in fermento, perché vi erano alte cariche dello Stato
italiano, in merito ad una iniziativa che si ripete dal 2007 “Il viaggio della memoria”,
organizzato dal MIUR. Nel nostro hotel c’erano diverse troupe televisive intente ad
intervistare personalità importanti come lo storico Marcello Pezzetti, uno dei massimi
studiosi italiani della shoah, oltre che consulente storico di film come “La vita è
bella” e “Schindler’s list”. Ma la presenza che più ci ha emozionati è stata quella di
Oleg Mandic, ora ottantacinquenne, sopravvissuto ad Auschwitz.
Oleg è stato l’ultimo bambino vivo ad uscire da quell’inferno ed ora gira nelle scuole
italiane per raccontare il suo vissuto, la sua terribile esperienza. Abbiamo potuto
scambiare alcune parole con lui e ne siamo stati onorati. Sul suo braccio vi era tatuato
un numero, quello con cui venivano “marchiati” tutti i deportati. L’emozione di
quell’incontro è stata fortissima e una frase ci rimarrà per sempre impressa: “Non
dimenticate ragazzi, la storia non va dimenticata”. Carichi emotivamente di questo
incontro, il giorno dopo ci siamo recati ad Oswiecim, meglio conosciuta come
Auschwitz, nuovo nome che i Tedeschi diedero alla cittadina polacca.
Era una giornata fredda, a tratti vi era anche della nebbia e il paesaggio nell’insieme
metteva tanta tristezza. Con la nostra guida abbiamo iniziato la visita e l’insegna che
spicca all’ingresso del campo cita testuali parole: “Arbeit macht frei”, il lavoro rende
liberi. Una frase che stride con ciò che hanno dovuto subire i milioni di deportati che
hanno varcato quella soglia e ai quali l’unica libertà permessa era rappresentata dalla
morte. Un motto che, a detta della guida, rimarcava la violenza, la cattiveria dei
nazisti che volevano solo affermare la loro superiorità e che negli anni è diventato il
simbolo delle crudeltà subite dagli ebrei.
Abbiamo iniziato la visita sul campo, eravamo un gruppo di 20 persone e quello che
ricordiamo è il silenzio, ciò che si sentiva era solo il calpestio dei nostri passi.
Camminare lì dove sono avvenuti i peggiori crimini contro l’umanità ci ha addolorato
ma nel contempo resi sempre più consapevoli. Studiare la storia sui libri è ben
diverso che “calpestarla”.
La guida ci ha condotto nei vari blocchi, ora sono adibiti a museo, e ad ogni blocco la
nostra tristezza aumentava. Nelle nostre orecchie risuonavano solo le parole della
guida e parola dopo parola quella ferita della storia, letta sui libri o vista nei film, si
riapriva. Per noi ragazzi i blocchi più duri da affrontare sono stati tanti; il primo,
sicuramente, è stato quello dove sono conservati i capelli di chi arrivava ad
Auschwitz, capelli che venivano tagliati a tutti, uomini, donne e bambini. La guida ci
ha fatto subito notare come nelle foto esposte nei corridoi, non si riuscivano a
distinguere uomini e donne. Con le teste rasate, le divise a righe e le facce impaurite
non vi erano differenze e, in questo modo, neanche i fratelli si riconoscevano. Ogni
blocco conservava gli oggetti quotidiani di chi era giunto al campo pensando di
ricominciare una nuova vita: vi erano stoviglie, pennelli da barba, ecc. In un altro
blocco vi erano le valige dei deportati, con i loro nomi e la data di nascita; tra tutte
spiccava quella di una bimba di pochissimi anni e il senso di rabbia nel vedere ciò
aumentava sempre più.
Proseguendo la visita abbiamo visto il blocco che era dedicato a Mengele e alle sue
sperimentazioni sui gemelli, atte a voler trovare il modo affinché tutte le donne
tedesche potessero partorire solo figli gemelli. E’ in quel momento che abbiamo
ascoltato la storia delle sorelle Bucci, salve dall’olocausto solo per essere state
scambiate come gemelle. In seguito abbiamo visto i luoghi più atroci, come il muro
della morte dove un’intera famiglia fu fucilata sotto gli occhi del capofamiglia o la
stanza bunker, dove è morto Kolbe, francescano polacco, ora santo, che si offrì di
prendere il posto di un padre di famiglia che aveva tentato di fuggire, e che quindi era
stato condannato a morire di fame in cella. Il dolore e la rabbia per quei racconti così
tragici, a tratti davvero crudi, ancor di più per noi ragazzini, aumentava sempre più
ma la guida ci preannunciò che quello che avremmo vissuto nel campo di Birkenau
sarebbe stato molto più forte.
Così ci siamo spostati con un bus al secondo campo di concentramento, quello
sicuramente più duro che rende ancor meglio visivamente la crudeltà inflitta a milioni
di esseri umani. Se Auschwitz esternamente può sembrare un insieme di stabili in
mattoni e ciò che rende maggiormente l’idea di campo di concentramento sono le
barriere di filo spinato, a Birkenau al primo sguardo si respira morte. Non vi è più
nulla se non i perimetri delle baracche di legno, le macerie dei due forni crematori,
qualche baracca in mattoni e un binario, il binario della morte.
La guida ci ha condotti lì dove arrivavano i deportati con i vagoni e proprio lì dove
venivano smistati donne, uomini e bambini. Con un semplice cenno della mano il
medico del campo indicava chi fosse abile al lavoro o chi dovesse essere destinato
alle camere a gas. Un gesto di pochi secondi che decideva il destino di vite umane.
Bastava avere le lenti, piuttosto che zoppicare per essere mandato a morte. Per gli
altri era previsto un duro lavoro che combinato a dei pasti poco sostanziosi, li avrebbe
condotti nell’arco di tre o quattro mesi alla morte. Ebbene sì, la crudeltà di certe
menti aveva portato ad organizzare i pasti in modo che gli uomini non avessero il
dovuto apporto calorico. A ciò si aggiungevano le fredde temperature, che potevano
arrivare in inverno anche a venti gradi sotto zero, gli scarni vestiti che indossavano e
le pessime condizioni igieniche. Pian piano, privi di forze, i deportati non riuscivano
neanche ad alzarsi in piedi e venivano chiamati nel gergo del campo, “musulmani”,
per la postura che assumevano tipica dei musulmani in preghiera. Di lì a poco
sarebbero morti. Per tutti gli altri la morte giungeva per mano delle camere a gas
presenti a Birkenau. Si facevano entrare i deportati con la scusante di fare le docce
ma una volta all’interno, tramite delle colonne forate, veniva immesso lo Zyklon B,
che di lì a poco li avrebbe uccisi tutti. Birkenau è un campo che scuote le coscienze,
che fa riflettere, fa piangere, ci fa capire di quanta crudeltà possa macchiarsi l’uomo.
L’ultimo luogo che ci ha fatto visitare la guida è stata una delle poche baracche
ancora in piedi a Birkenau. Un luogo dove centinaia di uomini dormivano ammassati
su tavole di legno e dove il freddo, la scarsa igiene e la presenza di ratti aggressivi, la
faceva da padrone.
Sono state quattro ore cariche di emozioni: le valige ammassate, i numeri
impressionanti delle vittime, le baracche, i forni crematori, tutto è stato un pugno al
cuore per noi; una atrocità del genere è avvenuta solo 75 anni fa e ad oggi entrambi
sentiamo ancor di più il valore della storia, perché dietro delle parole stampate su un
libro, ci sono storie di uomini, donne e bambini.
Birkenau ed Auschwitz non si dimenticano e non vanno dimenticati: “Chi non ricorda
la storia è destinato a riviverla”.
Luigi Campese e Giulio Piazzolla
III D