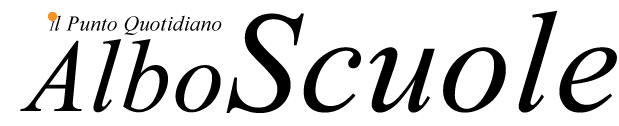ALLA GALVANI OPROMOLLA UNA LEZIONE SPECIALE CON GIOVANNI POLLASTRELLI, EX DETENUTO
La solitudine in cui si sprofonda pur trovandosi in tre in una stanza che a malapena può ospitare due persone, la difficoltà a condividere gli spazi con altri sconosciuti che spesso parlano una lingua diversa, la diffidenza, la paura. Due ore di lezione speciale, organizzate dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Galvani – Opromolla”, guidata dalla Preside Anna Scimone. Gli studenti, infatti, lo scorso 27 marzo, hanno partecipato, in modalità a distanza, all’incontro con Giovanni Pollastrelli, autore del volume “La mia vittoria”. Si tratta di un libro nato all’interno del Progetto Carcere UISP ed è stato già protagonista di numerosi incontri con le scuole di altre province italiane. “La mia vittoria” narra l’avvincente storia del riscatto personale di Giovanni Pollastrelli che comincia in carcere e finisce nei campi da calcio. Due ore di lezione intense che sono servite innanzitutto a sgretolare molti pregiudizi e durante le quali l’autore ha parlato sinceramente degli errori commessi e di come sia riuscito a correggerli. Un racconto toccante che lancia un messaggio di grande spessore per le nuove generazioni: dagli errori si può e si deve imparare. Pollastrelli vive a Pesaro, ma è napoletano. “Napoli è la mia casa: tra la devozione per San Gennaro e Maradona, le capuzzelle dei morti e il Palazzo Reale, la verità è che vivere a Napoli non è semplice per nessuno – ha raccontato agli studenti – In quel teatro a cielo aperto convivono anime contrastanti, e per quante bellezze si possano incontrare, ci sono aspetti che purtroppo la rendono famosa nel mondo più di qualunque Cristo Velato. Senza cadere nella banalità delle frasi fatte, diciamo che il contesto sociale non è facile. Ed è lì che ho iniziato a fare il pataccaro, sarebbe a dire quella persona che, quando vi fermate negli autogrill dell’autostrada vi invoglia a comprare qualcosa a poco prezzo: un video, una telecamera, un telefonino, e alla fine non vi lascia nulla, se non la classica patacca. Insomma, l’affare lo facevo io. Vi dirò che ero pure molto bravo, tanto da ricevere complimenti da persone che avevo truffato, che appena mi rincontravano mi offrivano addirittura il caffè. Col passare degli anni mi sono ritrovato all’Autogrill Montefeltro di Riccione: non è proprio un trasferimento… diciamo che, come libero professionista, ho allargato un po’ quello che gli esperti chiamano “raggio d’azione”. Giovanni ha raccontato ai ragazzi il suo passato, diviso in sette carcerazioni: “Non ne vado fiero, statene certi! Parlarne mi rinforza, perché quella persona non esiste più”. Uno dei momenti più forti dell’incontro è stato quando uno degli studenti gli ha chiesto: “Lei si vergogna di quello che ha fatto?”. La risposta di Giovanni è stata: “Il Giovanni di oggi non si vergogna di quello che ha fatto, anzi… usa l’esperienza che ha vissuto per raccontare ai giovani che sbagliare è umano, ma dagli errori si può e si deve imparare. Ho cominciato a conoscere il carcere nel 1986 a Orvieto e vi posso dire una cosa: il carcere ti priva della libertà, diventi un numero di matricola senza affetto e senza famiglia: in una parola, sei solo… e quando una persona (perché stiamo parlando di persone) resta sola, una strana legge della vita fa sì che possa sbagliare strada più facilmente. Il pensiero nel carcere è rivolto in una sola direzione: quella della libertà, e questa benedetta parola la cerchi ovunque, persino nelle droghe. Io ho fatto uso di stupefacenti, non lo nego, perché qualsiasi cosa rappresenti un’evasione dalla quotidianità della cella viene accolta con entusiasmo. Parliamo di una prigionia quotidiana, qualcosa di paranoico e innaturale: immaginatevi una linea di frontiera che separa il bene dal male, una zona grigia dove le persone combattono i propri fantasmi. Questo limbo è un po’ come la stanza degli specchi, dove sei costretto a guardarti ogni giorno e dove si riflettono le situazioni di allarme sociale, le statistiche sulla sovrappopolazione delle celle, la speculazione delle testate giornalistiche, tutte cose che creano un clima di paura anziché di informazione e buonsenso. Io in quel rilesso non mi riconoscevo più. Ho cominciato ad avvertire un cambiamento. L’ultima carcerazione che ho fatto, parte dal 2009: ho cominciato a fare un esame, a mettermi in gioco e andare dall’altra sponda delle ideologie. Mi sono ritrovato così a seguire un percorso formativo e sono diventato arbitro. Io arbitro? A me il calcio è sempre piaciuto ma se c’è una cosa che posso dire di me e del mio passato, è che le regole mi sono sempre state antipatiche, non mi appartenevano proprio. Come sapete, però, per ogni pazzo in giro c’è qualcuno che lo supera: così nel 2012, con il mio attestato da arbitro, Umberto Alessandrini mi ha detto “vieni a trovarci per fare l’arbitro quando esci.” Ci sono andato e devo dire la verità, è stato emozionante confrontarmi con persone che non facevano parte del mio contesto: erano normali, andavano a lavorare… e mi davano fiducia. Così è iniziata: prendevo il mio borsone, uscivo, arbitravo e tornavo in carcere. Ora immaginatevi uno come me che si ritrova sul campo da calcio con la divisa da arbitro, con tutto quello che comporta il ruolo. Tanto per cominciare, l’arbitro ha sempre torto, da una parte o dall’altra. Una ti loda e ti difende, l’altra ti urla cornuto e ti prenderebbe a schiaffi a fine partita: dipende da chi vince. Il mestiere dell’arbitro, per quello che ho imparato, si riassume in una parola: autocontrollo. Mi sono detto: mamma mia, se sopporto tutto quello che mi dicono e difendo la mia idea perché si basa sul rispetto delle regole, allora qualcosa di buono dentro ce l’ho. Non sono poi quel concentrato di male, errori e reati. Se ne dicono tante sul calcio, per me è stato fondamentale per capire che nella vita bisogna rispettare le regole. Le facevo rispettare in mezzo al campo e dovevo rispettarle anche io”. E ancora: “Oggi mi guardo indietro e penso che Giovanni di tanti anni fa non esiste più. Mi capita di camminare in strada da solo, spensierato, godendo del sole, quando c’è, o della pioggia. Le mie passeggiate hanno il sapore dell’aria, come il vento mi intrufolo in ogni angolo, percorro tutte le strade che voglio e poi alzo le braccia. Vaffanculo – mi dico – ce l’ho fatta, ho vinto io! Ora vivo il quotidiano della vita, non la paranoia del carcere. A voi sembra normale, ma tutti vogliono parlare di Giovanni di una volta. A me quel Giovanni non piace, ve l’ho già detto. A me piace il Giovanni che cita la costituzione: il lavoro è alla base della vita. Reinserirsi è importante e guadagnare onestamente è fondamentale. Purtroppo per un ex detenuto il reinserimento nel mondo del lavoro legale è una cosa tutt’altro che ovvia. Ma le carceri non si svuoteranno mai finché i detenuti saranno costretti a rivolgersi al mondo della criminalità per trovare un qualsiasi impiego come facevo io. Adesso ho capito che i soldi servono per campare, ma non sono tutto: a me basta quel poco per andare avanti. Lo ripeto sempre a chi mi ascolta: “Guagliù, io non tenghe nient’, però tengo tutt’e cose”. Se mi guardo indietro trovo un sacco di persone che non avrebbero scommesso un centesimo su di me, ma quelle stesse persone che mi avevano dato per “caso chiuso” ora si sono ricredute: questo è il riscatto. Mi sono riscattato, io sento di aver vinto. Ero un ragazzo di strada, un delinquente, ma oggi sono fiero di essere Giovanni Pollastrelli. Ieri avevo un vero codice della strada come legge della vita. Oggi sono vivo”. Un racconto emozionante, che ha coinvolto moltissimo gli studenti della “Galvani – Opromolla”. Pollastrelli, da anni, si reca nella scuole per lanciare appelli ai giovani, messaggi di speranza facendo capire che il carcere può redimere una persona come è successo a lui. “A voi giovani dico di seguire i buoni esempio perché la scelta della criminalità non porterà a nulla, se non al vostro fallimento. Non lasciatevi mai ammaliare dai cattivi esempi”.
Luigi Novi
LA PRESIDE ANNA SCIMONE: DA GIOVANNI UN’IMPORTANTE LEZIONE
Stabilire a chi spetti la giurisdizione dei discorsi morali e delle parole di “etica situazionale” potrebbe rappresentare la soluzione per far chiarezza sul loro autentico significato. Infatti, a volte si usano alcuni termini smarrendone l’accezione, sbagliandone la semantica, il loro procedere diacronico e, perdendone l’implicazione più profonda, si finisce con il fraintenderli e con il dimenticarli nel fluire rapido dei luoghi comuni. Questo capita di frequente soprattutto con alcune parole astratte, come ad esempio: libertà, legalità, lealtà, pentimento, uguaglianza, giustizia. Di questi lemmi, spesso credo se ne abbia solo un’infarinatura, una liquida frequentazione semasiologica, e di conseguenza, penso se ne dia per scontata la loro valenza, nella quotidianità, infatti, poche persone hanno effettivamente assaporato il gusto della solidarietà e pochissime hanno sentito il profumo della libertà. Gli antichi filosofi fisiocratici ritenevano che l’ acquisizione dell’ apprendimento si veicolasse attraverso due strade: il simile con il simile, oppure, mutatis mutandis, il simile con il dissimile, ritenevano, cioè, che la conoscenza dovesse avvenire per una sorta di contraddizione stridente. Secondo il loro punto di vista, di libertà e di legalità avrebbero potuto parlare esclusivamente gli esperti: magistrati, alti gradi delle forze armate, intellettuali, professori e tutti coloro ai quali attribuiamo potestà di discettazione, cognizione di causa, capacità di facondia infarcita di citazioni edotte, magari con una esperienza manualistica, o con trascorsi numerosi, ma “dalla parte giusta”. Noi della Galvani- Opromolla, in occasione della giornata della legalità, abbiamo scelto la dissonanza e abbiamo lasciato la parola a Giovanni Pollastrelli: scrittore da adulto, arbitro di calcio per passione -e forse per un innato ed insperato rispetto delle regole- semplicemente un uomo che, perduta la libertà fisica per disattenzione alla leggi umane, ha saputo ritrovare un’autonomia spirituale, dopo un lungo periodo di latitanza morale e di debito etico. Lui, che ha attraversato le Forche Caudine della solitudine sociale, il disimpegno umano di scelte di vita sbagliate, ha saputo entusiasmare i giovani studenti di una scuola secondaria di primo grado; i suoi pensieri, che credeva non facessero rumore, hanno suscitato un’esplosione di domande interessate, di riflessioni intelligenti, di commozione tangibile; le sue parole hanno icasticamente rappresentato la riscoperta delle piccole cose, dei piccoli gesti quotidiani, privi di importanza per chi non ha vissuto la schiavitù dell’essere recluso. Scandite con passione, le sue frasi ci hanno fatto riassaporare il più buono dei caffè, la più calda giornata primaverile, le fresche risate con gli amici, la bellezza del mare e di un tramonto; il periodare si è trasformato in suoni e storie raccontate, in immagini riprodotte e, per un’ora tutti noi: studenti, insegnanti, genitori siamo stati attenti a non lasciarci sfuggire il senso di ciò che ci veniva comunicato. “La mia vittoria” non è un libro, ma un piccolo manuale di istruzioni su come sia possibile ristrutturare il senso umano delle esperienze, di quanto sia sempre importante riconoscere la potenza vivida della speranza e di quanta fatica occorra per capire che i cambiamenti possano e debbano avvenire nella vita, anche se epocali, totali, sconvolgenti. Le 25 pagine del libro delineano un ideale viatico per affrontare le difficoltà più disperanti e fungono da vademecum per aiutare chi le legge a capire che il puzzle della propria esistenza si può sempre ricomporre, che tutto, volendo, “si può fare”!
Kant sosteneva che i grandi libri non sono necessariamente libri grandi ed i tomi imponenti non sempre sono scritti per insegnare (lasciare un segno): spesso poche pagine riescono a condensare un’intera vita trascorsa in manicheistiche traversie – tra la disinvolta scelta del male e la desiderata ricerca del bene-, possono rappresentare un invito a meditare sempre sulla possibilità di perdonare e perdonarci autenticamente, tendono a suggerire di non desiderare sempre stolide e semplici risposte, ma a porre domande logiche e difficili, a valutare senza giudicare e a considerare ciò che ci capita sotto l’egida del generale, mai solo del “particulare”.
“Giovanni, ti sei pentito del tuo passato?” ha chiesto uno studente con sincera partecipazione, “No, mai! Mi sono ravveduto, ed è una cosa differente”. Le vicende umane non presentano mai tinte nette e distinte, ma nuanges cangianti che si fondono e, spesso, si confondono: ravvedersi in fondo non significa rigettare ciò che è stato, ma vedere il futuro con altri occhi, con la volontà di scegliere altre strade. Se ci pensiamo potersi ravvedere, senza una fideistica costrizione sociale, è alla fine il più convincente gesto di lealtà verso sé stessi ed il più grande esercizio di libertà …Grazie, Giò!
Professoressa Anna Scimone, DS Galvani – Opromolla