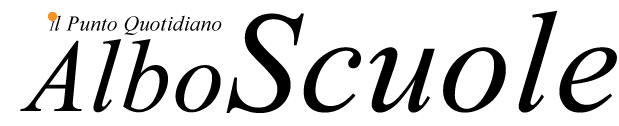di Francesco Salvetti
La malattia è un topos letterario. Il flagello epidemico per antonomasia, soprattutto, ci ha fatto effettivamente (e simpaticamente) visita più o meno con la stessa frequenza con cui ricorre nella storia delle opere artistiche della nostra cultura (da Sofocle a Manzoni, passando per Boccaccio, solo per citare gli indispensabili… )
La Peste di A. Camus, scritto e ambientato negli anni ’40 del secolo scorso, si distingue dai suoi illustri precursori sia per il suo (apparente – e non c’è bisogno di spiegare perché -) anacronismo sia per la specifica valenza metaforica di cui si carica la pestilenza (siamo negli anni del dilagare del nazi-fascismo in Europa). Nel romanzo si narra di un’improvvisa e inaspettata epidemia di peste che travolge Orano, città costiera dell’Algeria francese, costringendo gli abitanti ad un lungo periodo di angoscia, di costrizione forzata e di isolamento. La sapiente ricostruzione dello scenario complessivo ci può senz’altro aiutare a collocare le nostre esperienze di questi giorni nella giusta prospettiva.
A dispetto del titolo, e del crudo (per quanto sobrio) realismo con cui talvolta i tragici effetti del morbo sono descritti, il soggetto della narrazione non è la peste (l’epidemia che tiene in scacco un’intera città per quasi un anno). Il vero soggetto è la comunità umana di Orano. Sarebbe del resto alquanto superstizioso, considerando la cornice filosofica in cui si muove l’autore, identificare il soggetto in qualcosa che non sia l’uomo. Non a caso il dott. Rieux, protagonista e narratore (ma questo si scopre solo alla fine) di tutta la vicenda, si riferisce ripetutamente alla peste, e alle sue più crudeli e cruente epifanie, come ad un che di “astratto”, di “irreale”, fino a rilevare sorprendenti analogie: “la peste, come l’astratto, era monotona”. Ma ad una metafisica dell’astratto Camus preferisce di gran lunga una fenomenologia del concreto, che lo porta a concentrarsi sul microcosmo di Orano, forzatamente chiuso in sé stesso e circoscritto nelle sue dinamiche socio-esistenziali, ma anche (e forse proprio per questo) specchio dell’umanità intera. Il romanzo, dunque, non può che parlare anche di noi, e tutti possiamo in effetti ritrovare in noi (soprattutto in questi tempi di introspezione forzata) un po’ di Rieux e un po’ di Tarrou, un po’ di Rambert e di Grand, di Paneloux e di Cottard, personaggi antitetici eppure in qualche modo complementari.
E chi saremmo, allora, noi? Anche qui Camus sembra guardarsi soprattutto dal pericolo dell’astrazione e dalla tentazione dell’astratto. Nessuna categoria etica o antropologica può circoscrivere quello che siamo, nemmeno in una situazione.limite come quella della malattia e dell’esposizione costante al rischio supremo. Non siamo né vili, né coraggiosi, né egoisti né solidali, né forti né deboli. Santità ed eroismo non sembrano costituire possibilità esistenziali percorribili e nemmeno autentiche, ridotti come sono a (rivelandosi niente più che) “complessi di abitudini”. La peste non rivela così nessuna natura umana precostituita (con buona pace di padre Paneloux), ma semmai ci ricorda una volta per sempre che “siamo quello facciamo”, inseparabili dalle infinite pratiche sempre rinnovantesi che ci tengono insieme e ci tengono nel mondo; dove tutto si tiene, dove forse tutto eternamente ritorna (si vedano le ultime amare riflessioni di Rieux) ma dove certamente tutto passa e transita. Comprese le pandemie (di ieri e di oggi…)