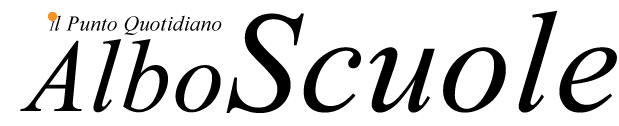Il 13 marzo 1964 Kitty Genovese, una donna di New York, fu accoltellata a morte nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Kew Gardens.
Nessuno dei 38 residenti che assistettero, seppur a spezzoni, all’inseguimento e all’omicidio della donna le prestò soccorso o si preoccupò di chiamare la polizia.
L’evento ebbe un forte impatto sulla popolazione e divenne il simbolo di un fenomeno sociale oggi conosciuto come “effetto testimone”.
In una situazione di emergenza, la probabilità che uno spettatore intervenga cala drasticamente all’aumentare del numero dei testimoni presenti sulla scena.
Far parte di una massa o di un gruppo “alleggerisce” il peso delle nostre responsabilità in relazione ad una qualsiasi emergenza sociale e ci spinge quindi a non intervenire, rassicurati dalla possibilità che qualcun altro abbia già agito al posto nostro.
È semplice comprendere le dinamiche di questo meccanismo pensando, ad esempio, alle numerose volte in cui abbiamo scorto da lontano le fiamme di un incendio ed esitato ad avvisare le autorità competenti, convinti che qualcun altro avesse già segnalato il pericolo.
Si tratta di una forma di apatia e indifferenza che ci manda in tilt, ci rende incapaci di agire e spegne quei campanelli d’allarme che inevitabilmente si attivano nel nostro cervello in situazioni di pericolo.
Due psicologi, Latané e Darley, analizzarono le dinamiche con cui l’effetto testimone si manifesta, per tentare di individuarne le origini. Essi giunsero alla conclusione che, oltre alla diffusione del senso di responsabilità, ad influire sul nostro comportamento in situazioni di pericolo è la paura di essere giudicati da chi ci circonda, di agire in maniera sbagliata o essere considerati responsabili dell’accaduto.
La probabilità di intervenire diminuisce inoltre se la situazione è ambigua o non viene percepita, a primo impatto, come realmente pericolosa. Infatti, in questo caso si tende a quantificare il pericolo in base alla reazione di chi ci circonda, che a sua volta si baserà sulla nostra. Così la massa rimane inerme, immobilizzata dal dubbio.
Se con la vittima intercorrono rapporti di parentela o amicizia, allora le probabilità di agire crescono, in quanto ci si sente in dovere di aiutare coloro con i quali abbiamo instaurato un rapporto.
Molte altre volte, invece, ci sentiamo semplicemente incapaci di intervenire, temiamo per la nostra incolumità e facciamo la scelta più semplice: lasciamo prevalere la legge del più forte.
Che quindi il nostro cervello non sia egoisticamente programmato esclusivamente per l’autoconservazione?
Non dimentichiamo che a influire sui nostri comportamenti non è soltanto la sfera più istintiva, ma anche quella della volontà; è perciò nostro compito combattere la dilagante deresponsabilizzazione promuovendo la solidarietà e l’empatia. Solo allora, forse, potremmo vantarci di vivere in una società coesa e-perché no- persino un po’ più giusta.