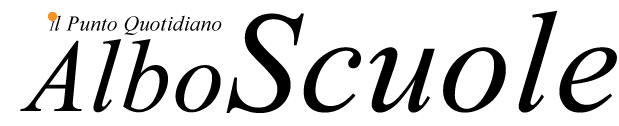Rebecca De Maria – C’è un bambino. Barcolla sul terreno roccioso fino al fiumiciattolo che scorre in mezzo al suo villaggio e felice ci sguazza dentro. La sua è una terra nera, un tempo forse ospitale, ora illuminata giorno e notte da fuochi, luci, grida. Gli adulti del villaggio si occupano dei campi da coltivare, ma i frutti del terreno non bastano per tutti già da qualche tempo. Il cibo e l’acqua scarseggiano ogni giorno, così i grandi risparmiano le energie per lavorare, arare, mietere, raccogliere e non hanno la forza per sorridere. C’è qualche risata che come un’eco risuona per le capanne stanche, appartiene ai bambini, ai piccoli, agli innocenti, le cui membra ancora ricordano la gioia del muoversi. Si rotolano insieme nel fiume fangoso, dai fondali rossastri, abituati ad essere circondati dal dolore di vivere. Il bambino continua a nuotare nell’acqua putrida. Si diverte ad immaginare la vita dentro il fiume, un pesce, un granchietto, delle alghe, creature ormai stroncate dalla morte che avanza. Nuota ancora qualche metro, prima di sentire una voce rauca e sfinita strascicare il suo nome. Si chiama Tutto ed ha 7 anni ed è il suo ultimo giorno con gli altri bambini. Ora è abbastanza grande per aiutare gli adulti del villaggio nei campi: ora deve dire addio ai giochi puerili, alla felicità di correre e camminare. Si alza dal fiume sporco e un po’ infreddolito, ma ignora i vestiti logori che, come una prigione, gli si raggrinziscono sulla pelle e si dirige deciso verso il terreno coltivato. I suoi grandi occhi neri scrutano il cielo sempre grigio. Spera che un giorno se ne andrà dalla sua piccola casa triste, spera che riuscirà a vedere, un giorno, il cielo arancione e rosa che qualche anziano dice di aver ammirato da giovane. Corre per l’ultima volta verso i suoi genitori, che con un cenno lo guardano arrivare; gli porgono un vecchio attrezzo consumato, vorrebbero sorridergli, dirgli che un giorno andrà meglio. Non lo fanno. Non ne hanno il cuore. Tutto inizia a lavorare. Passano i giorni, poi le settimane, poi gli anni. È il decimo inverno che Tutto passa nel suo villaggio ed il clima quasi sempre mite ha portato con sé un vento crudele. Uno dopo l’altro, gli adulti si ammalano e sempre di meno rimangono con le schiene curvate nei campi. Tutto è uno di questi; insieme ad altri più giovani continua a colpire il terreno con scossoni poderosi. Non è il più forte, o il più alto o il più veloce o il più resistente, forse il più ottimista, nonostante le mani sanguinanti e le prime rughe a solcargli il volto. Alza lo sguardo all’orizzonte, concedendosi una piccola pausa: sono pochi, quel giorno, e non ci sono adulti a redarguirlo stancamente. Sta per tornare al suo lavoro, quando scorge un piccolo bagliore dietro la collinetta che da anni si impegna a coltivare. È attratto dalla luce come una falena e, senza farsi notare, si avvicina al confine con l’altro villaggio. A passi felpati cerca di riconoscere l’origine del guizzo, quando sente delle grida attutite al di là del pendio. Voglio aiutare chiunque abbia ancora la forza di gridare, pensa. Si decide a lasciare la sua vanga, la nasconde sotto un ammasso di pietre e avanza verso la pianura. Sente che ciò che sta facendo è giusto, si sente vivo dopo tanto tempo, come se fosse d’un tratto tornato bambino e stesse giocando ad acchiappare i suoi amici. Si accorge di correre dopo qualche secondo. Intanto le grida si fanno più forti e sempre più lampi squarciano il velo grigio che copre ogni cosa. Tutto si ferma, affascinato, cercando di vedere oltre le luci il velo colore del cielo. Vede solo nero. Forse è per questo che non vede nulla. Non si accorge nemmeno dell’esplosione, non sente il rumore del terreno che cessa di esistere, o forse lo sente, ma è comunque troppo tardi. Il suo corpo viene circondato da fiamme, sangue e grida terrificanti e semplicemente sparisce insieme ai germogli che iniziavano a crescere testardi sul terreno. Passano alcuni secondi e il fumo causato dalla bomba si dirada. Dietro la cortina grigia, il niente. Di Tutto non è rimasto nulla: non un dente da latte, non una maglia strappata e logora, non un osso nero, non una mano, non un sorriso. Viene il vento, che porta con sé le ceneri di qualcuno che non esiste più. Tornano indietro, come attratte dalla loro vita precedente, e raggiungono quel villaggio al confine della guerra. Gli adulti hanno sentito l’eco delle bombe dalle loro capanne e si alzano dai letti malati per andare nei campi pieni di paura. C’è una donna che piange sommessa dopo aver scambiato dei sussurri con gli altri che, fino a poco prima, continuavano ignari a lavorare la terra. Un uomo guarda il cielo rosso e grigio. Qualche pezzo di cenere si posa sui suoi capelli bianchi. Ha 30 primavere, ma il suo dolore è secolare. È il terzo figlio che perde. Vorrebbe piangere, vorrebbe abbracciare la donna che un tempo sapeva amare. Vorrebbe dirle che andrà meglio. Ma non lo fa. È troppo stanco. Dall’altra parte del mondo, altre grida. Altre luci. Altri lampi. Pianti e urla, e poi lacrime di gioia. Il vagito di un neonato, che apre i suoi grandi occhi neri. È felicità, ma anche un avvertimento: ognuno di voi è Tutto.