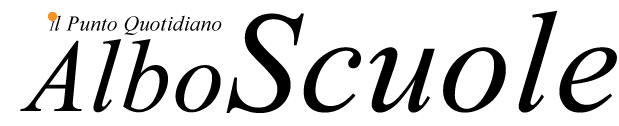di Francesco Magi – Omaggio alla Merini!
Alda Merini, una donna che ha raccontato se stessa, le sue passioni, i suoi dolori, in poesia, in aneddoti, in brani della propria storia. Comincia a comporre poesie a sedici anni ed a ventidue è già conosciuta per le sue spiccate qualità di scrittrice. Ma Alda Merini giunge alla notorietà pubblicando pagine drammatiche della sua vita da reclusa in manicomio e poesie di elevata ispirazione, di delicato e raffinato sentimento.
I pazzi, è sempre stato detto, e ancora da molti si afferma, non comprendono, non provano desideri, emozioni, non sanno pensare, sognare, non sono più persone con un diritto alla dignità, al valore, al riscatto, non hanno un senso, un’anima; se stanno male lo fanno in modo sbagliato, da “pazzi”, non sembrano soffrire realmente; le manifestazioni del dolore, dell’angoscia vengono sbrigativamente giustificate come emanazione diretta della malattia e non quali rappresentazione di un animo ferito, lacerato, devastato, dalla vita, dalla fragilità degli affetti più che da disfunzioni cerebrali.
La condizione dei manicomi, descritta da Alda Merini, ci riporta ad una realtà, mai completamente superata, di esclusione, di emarginazione che spesso i malati di mente, i dementi incontrano, vivono nell’ambiente famigliare e sociale di appartenenza.
Ciò che più colpisce delle parole scritte dalla poetessa milanese riguarda il vissuto, la coscienza, il dolore, le atroci, incredibili ingiustizie subite dal malato. Un grido, una richiesta, un moto di ribellione, una tenerezza rubata, uno sguardo angosciato, triste, smarrito, un lamento, un pianto, specie se fuori orario, vale dire nel tempo intoccabile del riposo, della calma notturna venivano percepiti come azioni di disturbo. Al malato era vietato, impedito di fare il malato, se non quando e nel modo decisi e stabiliti dall’istituzione. Scrive la Merini: “Il disturbo consisteva nell’insonnia, nell’angoscia. Queste cose disturbavano noi non le infermiere. Ma noi eravamo capaci di dare “disturbo”, e ciò veniva segnato con puntualità (…) ci era proibito tutto, anche di soffrire di insonnia. E l’insonnia spesso ci visitava, come visita qualsiasi persona su questa terra”.
“Avevo sete di verità e non capivo come ero potuta capitare in quell’inferno (…) ero spaventata dall’oscenità di ignoranza che si adoperava in quei luoghi. Il demente viene considerato “incapace di intendere e di volere”. Eppure, sotto la diagnosi serpeggiava quieta la mia anima dolce, rasserenante, un’anima che non era mai stata tanto luminosa e vitale (…) adoperai il silenzio, e mi venne fatto di incontrarvi il mio io, quell’io identico a se stesso, che non voleva, non poteva morire”.
La testimonianza di Alda, la sua vita da reclusa e da sofferente, invita a pensare, a riflettere sulla dignità, sui diritti, sulla libertà di esprimersi e di essere accettati così come si è, quale momento essenziale per poter comprendere e tutelare, eventualmente cambiare e ricominciare.
“Dio lascia a tutti un frammento della propria umanità”; è un pensiero della Merini rivolto a se stessa ed ai compagni ancora più sfortunati e sfigurati dal dolore della pazzia e dall’isolamento, dall’intolleranza all’interno dell’ospedale psichiatrico.
Dice Alda Merini: “Che cosa mi manca? Mi mancherebbe tanto di morire, perché io l’inferno della vita me lo sono goduto tutto”. E dal suo inferno vissuto, raccontato, dalla storia del suo dramma, di donna persa e ritrovata, dalla sua poesia scaturita, strappata alla lacerazione del cuore e della mente forse un po’ tutti usciamo più sgomenti e più arricchiti.